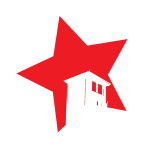“Dicevano: meno diritti, più crescita. Abbiamo solo meno diritti”. Così recita la quarta di copertina del saggio “Non è lavoro, è sfruttamento” (Laterza), che nel 2017 ha pubblicato, con enorme successo, Marta Fana, studiosa di economia e politica e giornalista.
Il libro riassume la ricerca condotta dall’autrice attraverso gli sfaccettati e complicati aspetti che pervadono il tema del lavoro, in un’epoca, la nostra, che ha visto l’ultimo governo della sinistra liberale a staffetta Renzi-Gentiloni, svendere gli ultimi cocci del concetto stesso di lavoro, erodendo diritti e precarizzando le esistenze di milioni svalutando e svuotando il tempo di vita degli individui in nome di una fantomatica “flessibilità” che avrebbe portato ad una ancora più evanescente “crescita”.
In un contesto di rapporti di forza completamente sbilanciati tra detentori dei mezzi di produzione e lavoratori ed in una fase storica di attacco ultra-aggressivo del capitale alla trasformazione del lavoro in valore l’introduzione dello zoppicante “reddito di cittadinanza” gialloverde inserisce una variabile da osservare da vicino.
Dalla frase in quarta di copertina è stato tratto uno spettacolo teatrale dal titolo “Abbiamo solo meno diritti”, in scena sabato 13 ottobre al Laboratorio Sociale. Per avvicinarci ad esso, abbiamo fatto quattro chiacchiere con Marta Fana sullo stato delle cose nel mondo del lavoro, della politica e dei diritti che ci hanno tolto.
Sia tu sia Angelo D’Orsi avete introdotto i vostri libri, “Non è lavoro è sfruttamento” e “Gramsci. Una nuova biografia”, parlando di Michele, trentenne di Udine morto suicida nel 2017 a causa della sua condizione di precarietà. Michele è stato assunto come simbolo di una generazione, lui e quella frase “io non ho tradito, io mi sento tradito”. Qual è secondo te la strada che deve percorrere un giovane precario per non farsi lacerare dalla stessa perdita di speranza che ha attanagliato Michele? Qual è la strada da percorrere per renderci conto che “uniti possiamo vincere anche noi”, come scrivi in un memorabile passaggio del tuo libro?
Credo che bisogna ricominciare ad analizzare i fenomeni in cui viviamo per prendere coscienza della nostra condizione e di chi ci sta attorno. Purtroppo è complicato in un contesto in cui siamo costantemente bombardati (e non a caso) di retoriche e narrazioni che vogliono fomentare la competizione individuale e in fin dei conti l’individualismo più sfrenato. In questo modo non riconosciamo i nostri colleghi come alleati ma competitor, la cassiera che rallenta perché stanca non una lavoratrice come noi ma qualcuno che ci deve qualcosa, spesso il tempo che qualcun altro ci ruba, e deve sbrigarsi. La presa di coscienza contro lo sfruttamento è la prima arma per stabilire quali sono le alleanze reali ed efficaci per lottare uniti. Non si può lottare insieme ai nostri sfruttatori.
 Un capitolo di “Non è lavoro è sfruttamento” è dedicato al concetto di flessibilità che tu definisci di destra, decostruendo anni di propaganda di partiti come il PD che ci hanno fatto credere di dover essere il più multitasking possibile (introducendo, tra l’altro, la parola stessa nel linguaggio comune). Puoi brevemente spiegarci cosa intendi?
Un capitolo di “Non è lavoro è sfruttamento” è dedicato al concetto di flessibilità che tu definisci di destra, decostruendo anni di propaganda di partiti come il PD che ci hanno fatto credere di dover essere il più multitasking possibile (introducendo, tra l’altro, la parola stessa nel linguaggio comune). Puoi brevemente spiegarci cosa intendi?
Diciamo che tutti i governi – centro destra e centro sinistra – si sono cimentati con una certa diligenza a distruggere i diritti in nome della flessibilità. Più precisamente la flessibilità è il concetto teorico applicato da tutta la teoria (e ideologia politica) del neoliberismo secondo cui c’è disoccupazione perché la gente non vuole lavorare e le imprese assumono poco quando ci sono rigidità nel mondo del lavoro. Queste rigidità sono i sindacati, i salari, il costo del licenziamento, i sussidi di disoccupazione. Come si legge nei rapporti dell’Ocse e nelle leggi che istituiscono le riforme del lavoro, la flessibilità serve per rendere il mercato del lavoro più vicino e confacente al sistema delle imprese che devono agire in libertà. Quindi nella sostanza far sì che i salari possano diminuire, che i lavoratori possano esser licenziati a piacimento ma anche usati come vuole l’azienda, unico soggetto titolare di diritti.
“Non è lavoro è sfruttamento” è uscito nell’ottobre del 2017, in pieno governo Gentiloni. A giugno si è insediato il governo Conte e il ministro dello sviluppo economico e ministro del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio ha varato il cosiddetto “Decreto Dignità”. Cosa cambia per i lavoratori e le lavoratrici e quali sono, secondo te, i punti critici del decreto-legge?
Cambia molto molto poco e la direzione è tutt’altro che favorevole nel suo complesso. Hanno liberalizzato i voucher ad alcuni settori di servizi come turismo e alberghiero, cioè quelli dove i livelli di sfruttamento sono elevatissimi; il governo piuttosto che garantire maggiori diritti a lavoratori già sfruttati ha preferito dare più mano libera alle aziende per rendere ancor più precario il lavoratore. Non si dica “fanno nero meglio i voucher” perché 1. I voucher non hanno mai risolto il nero anzi gli studi in merito dicono che lo ha semmai aggravato e 2. Perché se esiste il nero, la politica prova a sconfiggerlo assumendo come parte lesa quella debole del lavoratore non quella dell’impresa pronta a tutto. Il secondo caposaldo è stato ridurre a 24, invece che 36, i mesi massimi per il tempo determinato. In principio è un provvedimento che riduce la precarietà, ma nei fatti ciò non accadrà. Un motivo su tutti: le aziende hanno il solo vincolo di non superare il 20% di occupati a termine sul totale dell’organico e il Jobs Act aveva anche eliminato il diritto del lavoratore ad essere assunto a tempo indeterminato se tale soglia fosse superata. Quindi le imprese hanno ancora la libertà di sostituire un lavoratore con un altro allo scadere del termine per quello precedente. Insomma, i lavoratori potenzialmente ruoteranno piuttosto che essere stabilizzati di più. Inoltre il 30% dei contratti a tempo determinato dura meno di un mese e il Decreto Dignità non incide minimamente su questo che è molto grave. Così come non interviene sui punti rilevati dalla Cassazione sugli indennizzi in caso di licenziamento ingiustificato, non interviene su tutte le forme di lavoro povero e gratuito.
Di diritto al reddito in forma universale ci siamo occupati fin dal primo numero l’introduzione di un salario minimo per legge è una misura di politica sociale da te auspicata. Il reddito minimo del M5S, definito “di cittadinanza” è palesemente una misura di workfare. Il rischio è di precarizzare ulteriormente e di obbligare i lavoratori al “lavoro qualsiasi e a qualsiasi condizione”. A noi sembra che abbia qualcosa a che fare con il piano Hartz IV tedesco, visto cosa ha creato quel modello sul tessuto sociale tedesco e visto che il modello M5S è ancora più grossolano c’è poco da stare allegri. Cosa ne pensi?
Penso che man mano che i dettagli emergono, perché va detto che non hanno presentato una proposta organica da leggere in una volta, la situazione peggiora. Sembra un incubo questo sistema: lavoro gratuito, fino a 6 anni di galera per chi poi si fa qualche ora in nero, deve essere speso solo in consumi morali e in negozi italiani, verrà dato solo a chi risiede da più di 10 anni in Italia. Di emancipatorio non c’è davvero nulla. E’ un reddito di sudditanza.
Fino a che punto ti spingi ad auspicare un reddito di base? L’estensione del reddito alla sua universalità su base ridistributiva del prodotto di plusvalore, in un’ottica di fine del lavoro e di riconquista della totalità del tempo di vita sta nelle tue corde?
Affinché una forma di reddito abbia tutte queste caratteristiche servono condizioni politiche, altrimenti si ricade inevitabilmente dentro il workfare o strutture simili. Le condizioni politiche sono inevitabilmente incompatibili con il sistema capitalistico. Quindi credo che faremo prima a costruire queste condizioni, che poi si avvicinano molto a quello che è il socialismo, che lottare dentro il capitalismo per averne le briciole che ci consentirebbe. Chiudo dicendo che in nessun caso possiamo pensare al reddito senza affrontare il nodo della produzione – dei rapporti di produzione ho appena detto -, ma anche della produzione in sé: come, cosa, quanto produciamo.
Autori
Elio Balbo e Lorenza Neri
ph. Paulo Gambaudo