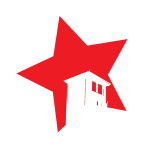Il rapporto con l’ambiente è una delle determinanti fondamentali dello stato di salute della popolazione umana poiché può influire indirettamente o direttamente su di essa. La salute è una condizione di equilibrio dinamico tra il soggetto e l’ambiente che lo circonda; gli individui vivono, attraversano e modificano l’ambiente, per questo motivo la salute è un diritto tanto individuale quanto collettivo. Riconoscere la salute come un diritto collettivo significa riconoscere l’esistenza di diritti riguardanti l’ambiente, significa affermare la necessità di tutelare forme di giustizia ambientale che non possono non essere strettamente legate, intrecciate e talvolta sovrapposte alla giustizia sociale.
Il diritto alla salute consta, pervade e viene pervaso dall’ecologia come disciplina che studia le funzioni di relazione tra l’uomo, gli organismi vegetali e animali e l’ambiente in cui vivono.
In senso più “attivo” si può dire che la salute agisce l’ecologia, facendo sì che l’uomo e l’ambiente vengano l’uno influenzati dall’altra; con il risultato pur logico che le relazioni tra uomo ed ambiente si fondano su un rapporto direttamente proporzionale al rispetto che il primo dona al secondo.
La società odierna, del capitale avanzato, ha una storia secolare di rapporto pessimo delle funzioni di relazione tra uomo ed ambiente, quest’ultimo ridotto a mero palco dell’attività umana, spogliato delle sue funzioni di sinergia con l’uomo e reificato a merce da sfruttare in vari e fantasiosi modi.
La traduzione in termini concreti di quanto l’uomo pratichi un attacco suicida alla biosfera ha le parole della perdita del diritto globale alla salute e del depauperamento della possibilità dei governi, stretti nell’intreccio da e con il capitale, di tutelare la salute dei cittadini.
Accade talvolta che in un’ottica di autoconservazione organica e funzionale i cittadini agiscano partendo dal basso per rivendicare, tramite l’agire collettivo, di comunità, il diritto alla salute ed al rapporto edificante tra uomo e ambiente, agendo una sinergia a più livelli: tra pubblico e privato, tra cittadini e istituzioni, tra vulnerati e vulnerabili.
É qualcosa di immensamente importante questo farsi comunità della comunità stessa, che viene definito resilienza di comunità: è un processo che mette in relazione un insieme di capacità, comportamenti e reti con l’adattamento in seguito ad un evento collettivo perturbante.
La complessità di questi temi è stata meravigliosamente affrontata nel quinto numero del Global Health Watch – report alternativo sulla salute mondiale pubblicato il 15 dicembre 2017.
La peculiarità del GHW report è che viene redatto in maniera collaborativa e partecipata da accademici, attivisti e attiviste di tutto il mondo, attinge i propri contenuti da una grande varietà di movimenti sociali, istituti di ricerca e gruppi della società civile, trattando alcuni dei problemi più cogenti nell’ambito della salute in tutto mondo. In questo numero un capitolo è dedicato all’Italia, all’impegno della comunità nella lotta per la salute di cui Casale Monferrato è un esempio.
“L’idea di raccogliere informazioni sull’esperienza di Casale nella lotta all’amianto non attraverso un convengo costruito da esperti accademici, dall’alto, ma attraverso un percorso durato un anno che ha permesso di incontrare associazione, cittadini, professionisti, familiari di vittime, nasce all’interno di una parte della comunità di psicologi che volevano portare all’attenzione il tema di un ambiente salubre come uno dei diritti fondamentali di una cittadina o di un cittadino.” Ci dice David Barbaglia, membro del DUPP – Diritti Umani Psicologi Piemonte, gruppo di lavoro interno all’Ordine degli Psicologi del Piemonte, i cui membri si muovono soprattutto al di fuori di esso.
Quando i nemici sono le multinazionali, le lobby del mercato globale e le conseguenze di comportamenti criminali hanno effetto sull’ambiente, quindi sulla salute, il meccanismo del “tanto non toccherà a me” non funziona. L’obiettivo primario diventa la presa di coscienza collettiva, rielaborare per ricostruire un’identità resistente e resiliente.
La sola città di Casale, che conta 34 mila abitanti, ha un’incidenza di 101,9 casi di mesotelioma pleurico su 100.000 per gli uomini e 43,4 per le donne, senza contare tutte le altre tipologie di tumori legati all’amianto.
Quando la sofferenza e il dolore raggiungono queste proporzioni è facile che l’individuo si isoli e perda reti e relazioni. Necessariamente la spinta e la forza nascono da un movimento collettivo, dalla comunità che si raccoglie per ritrovare fiducia perché la resilienza è individuale solo e soprattutto se anche processo collettivo.
Il gruppo di lavoro DUPP ha trovato in legge, memoria e consapevolezza i tre pilastri attorno ai quali si è costruita la resilienza di Casale. La conoscenza della Legge è utile per trovare possibili armi legali per difendere le persone colpite e per incriminare i responsabili, creando così un “caso” che potrebbe essere un esempio per tutti coloro che stanno combattendo contro l’inquinamento ambientale. La memoria è necessaria per trasmettere questa storia alle generazioni future e insieme alla consapevolezza di riconoscere tutti i pericoli che sono ancora presenti, di trovare soluzioni ai problemi.
L’esperienza di Casale Monferrato quale esempio di resilienza di comunità, è diventata una fonte di riferimento a livello internazionale, per combattere le attività contro l’inquinamento ambientale e la violenza, ma non è certamente la sola. La regione Piemonte è stata la fornace di un grandissimo movimento, quello No Tav della Val di Susa, che si è generato in seno alla capacità di una comunità forte e coesa come quella valsusina di produrre una grande forma di resilienza a partire anche, ma non solo, da istanze ambientaliste e di diritto alla salute.
 Il basso Piemonte e la provincia di Alessandria, da tempo definita la “terra dei fuochi del Nord-Ovest” è attraversata da alcuni esempi potentissimi di resilienza di comunità: come non citare la battaglia portata avanti da Genova ad Alessandria, passando per Arquata Scrivia e Tortona contro il Terzo Valico dei Giovi, o in una cornice ancora più propriamente comunitaria, quella portata avanti dalle comunità della Val Bormida contro la discarica a Sezzadio in cui agricoltori, tecnici, associazioni, privati cittadini, istituzioni e alcuni sindaci sono in prima fila per difendere il diritto alla salute sulla base del rapporto ecologico tra uomo ed ambiente.
Il basso Piemonte e la provincia di Alessandria, da tempo definita la “terra dei fuochi del Nord-Ovest” è attraversata da alcuni esempi potentissimi di resilienza di comunità: come non citare la battaglia portata avanti da Genova ad Alessandria, passando per Arquata Scrivia e Tortona contro il Terzo Valico dei Giovi, o in una cornice ancora più propriamente comunitaria, quella portata avanti dalle comunità della Val Bormida contro la discarica a Sezzadio in cui agricoltori, tecnici, associazioni, privati cittadini, istituzioni e alcuni sindaci sono in prima fila per difendere il diritto alla salute sulla base del rapporto ecologico tra uomo ed ambiente.
Queste esperienze sono dimostrazioni di buone pratiche e possono rappresentare ottimi esempi: la città di Alessandria versa in una situazione critica dal punto di vista dell’ambiente e della salute. A dirlo sono i report annuali di ARPA e Legambiente condotti sui 6 capoluoghi di provincia piemontesi: Alessandria è infatti seconda per tossicità dell’aria con una media molto alta di superamento dei livelli di polveri sottili PM10 sia nei valori annui, che giornalieri. Un dato drammatico, se si pensa che nel 2017 l’inquinamento atmosferico ha ucciso 90 mila persone in Italia.
Che non sia arrivato il momento per Alessandria ed i suoi cittadini di provare a ragionare, attivarsi e agire sinergicamente per cambiare lo stato di cose?
L’attivazione della resilienza di comunità è un’azione che può non originarsi unicamente nel rispondere alla puntualità dell’evento totalmente tragico, la possibilità di fare fronte ad uno stato di cose perturbante, può portare all’attivazione di capacità, comportamenti e reti atti a far fronte alla deriva, prima che sia tardi.

Autrice e autore
ph. Roberta Melchiorre