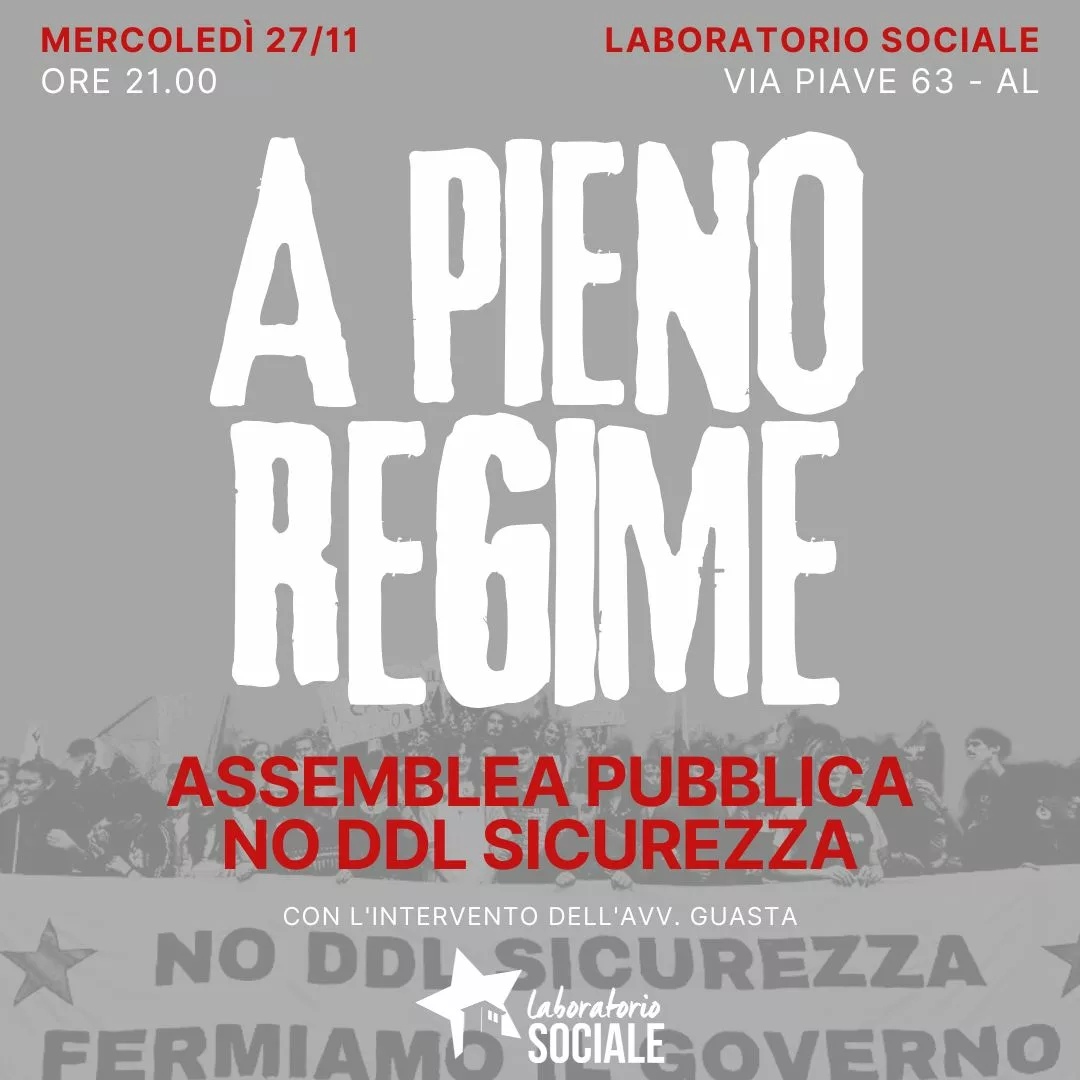Una delle questioni aperte in campo musicale, dibattute da tempo immemorabile, riguarda la presunta capacità che avrebbe la musica di influire in campo sociale e politico. Fior fiore di artisti, critici e pensatori si sono scontrati su questo argomento senza arrivare a una soluzione qualsiasi. Con il tempo mi sono formato un’impressione personale: credo che la questione sia mal posta. Valutando l’evolversi degli stili in campo musicale, limitando l’osservazione dal secondo dopoguerra a oggi, quello che salta agli occhi è il vero ruolo svolto da musicisti, cantanti e urlatori. La musica non cambia le cose, ma si limita (e non è un ruolo secondario) a fotografare i cambiamenti in atto. Tutto questo è accaduto in vari periodi storici. Nel lontano ‘67 gruppi come Jefferson Airplane, Grateful Dead e Quicksilver in quel di San Francisco diedero vita (assieme ad altri, molti altri) alla rivoluzione psichedelica, ma non furono inventori di un movimento: si limitarono a farsi colonna sonora dei fermenti che sussistevano già all’interno della società americana. Lo stesso può dirsi del punk, musica considerata erroneamente anglosassone, che ha dato voce, in Occidente, alle frustrazioni e alla rabbia di tutta quella generazione figlia dei mali del capitalismo e della società postindustriale che rifiutava regole e modelli imposti. Un esempio chiaro lo possiamo trovare anche a casa nostra. Agli inizi degli anni ‘90, in contemporanea con la disgregazione di una classe politica corrotta e maneggiona, è nata una bella scena musicale, i cui protagonisti hanno deciso di esprimersi attraverso il linguaggio del rap. Attori principali di questa scena sono stati Onda Rossa Posse (poi evolutasi in Assalti Frontali, gruppo attivo ancora oggi), Isola Posse All Star, Lion Horse Posse (rinominatosi in seguito Piombo a Tempo) e 99posse, solo per citare i più conosciuti. Tutti nati all’interno di famosi centri sociali, attraverso testi lucidi e diretti si sono fatti portavoce di un malcontento che esisteva da tempo nella società italiana e hanno rappresentato una boccata d’aria fresca per l’asfittico panorama sociale e musicale del Belpaese.
Vent’anni dopo possiamo affermare che non è cambiato assolutamente nulla, anzi, pare che le cose siano decisamente peggiorate, ma tant’è i ragazzi ce l’hanno messa tutta e hanno ben rappresentato una generazione di giovani che davvero avrebbero voluto cambiare le cose.
Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta e questo nuovo millennio ci consegna una realtà mondiale decisamente in movimento, Occidente (e Italia in particolar modo) a parte. Sono sotto gli occhi di tutti i cambiamenti che stanno accadendo nel mondo arabo. Regimi considerati eterni si stanno sgretolando per mano di una nuova generazione che reclama una vita migliore e regole sociali meno repressive. Attraverso i media siamo stati edotti circa i disordini e le proteste di piazza Tahir al Cairo, le manifestazioni a Marrakesh e la rivolta di Tunisi. Quello su cui i media non ci hanno informato riguarda la musica, gli inni della rivolta, chi attraverso l’espressione musicale ha documentato questo cambiamento epocale. E cosa emerge? Al pari dei ragazzi italiani degli anni ‘90, le nuove generazioni arabe si esprimono attraverso il rap, che è ormai divenuto in tutto il Medio Oriente la musica rivoluzionaria per eccellenza. Lontani dagli stereotipi classici americani, che vedono il rapper medio come un elemento ultraindividualista, teso alla ricerca del piacere e del denaro, i giovani arabi si sono riappropriati del messaggio originale dell’hip-hop e ne hanno fatto il veicolo per la propria rabbia. Due casi sono a mio parere esemplari. Il primo riguarda gli Arabian Knightz, gruppo egiziano il cui pezzo“I’m not your prisoner” è divenuto l’inno della rivolta cairota, conosciuto e cantato da milioni di ragazzi egiziani. Il secondo esempio riguarda il rapper tunisino Hamada Ben Amor, in arte EL General, arrestato dal regime in seguito alla pubblicazione del suo pezzo “Rais LeBled”, nel quale canta: “Caro presidente nel 2011 c’è ancora gente che muore di fame e che vorrebbe lavorare per sopravvivere. Ogni giorno vedo il serpente che picchia le donne con il velo, lo accetteresti tu per tua figlia? Vedo troppa ingiustizia e per questo ho deciso di mandare questo messaggio”. Dopo la fuga di Ben Ali e il crollo del regime, migliaia di persone hanno presenziato alla scarcerazione di Ben Amor e lo hanno acclamato come un eroe nazionale. C’è chi afferma che proprio il pezzo incriminato abbia incoraggiato la popolazione tunisina a scendere in piazza per le manifestazioni che alla fine hanno cacciato via Ben Ali.
Tutto questo ci porta al fulcro del discorso. Il linguaggio del rap ha contagiato quello che a noi piace chiamare il Terzo mondo. In un momento in cui gran parte della musica prodotta da artisti arabi è trasmessa dai media per intorpidire il pubblico allo scopo di eludere le questioni che riguardano le persone, l’hip-hop sta affrontando i nodi. Caso esemplare in tutto il Medio Oriente è quello della scena rap palestinese. Se l’ira è la madre legittima della musica rap in generale, l’esperienza palestinese è la migliore prova di questo legame con l’utero. Decine di gruppi hanno visto la luce negli ultimi dieci anni e il rap rappresenta un linguaggio attraverso il quale migliaia di giovani palestinesi possono esprimere la rabbia per un’identità apertamente negata. A differenza dei loro vicini egiziani, però, le cose per loro non sono cosi semplici (se di semplicità si può parlare citando l’esempio egiziano). Non devono fronteggiare un dittatore al quale ribellarsi, non c’è un governo al potere da sovvertire. La loro situazione è spiegata bene dalle parole di un mio conoscente palestinese: “Cosa può fare una ragazzo di Nablus o di Gaza? Ovunque si giri c’è solo merda! Si ritrova un futuro inesistente, Hamas su un lato, Al Fatah sull’altro e Israele in culo”. Sta proprio qui la grandezza dei giovani rappers palestinesi che, rifiutando le vecchie logiche di potere e di conflitto, si stanno proponendo come una nuova via. Una via diversa da quella della classe politica che li ha traditi, lontana da quella dei gruppi religiosi che li vorrebbero genuflessi e non pensanti. La loro è una forma di resistenza all’occupante basata non più sulla violenza fisica, ma che usa “il microfono come arma e le parole come proiettili”, secondo le parole di Saz, uno dei rapper più in vista dell’odierna scena rap palestinese.
Questi ragazzi si sono visti appioppare molte etichette: arrivisti, imitazioni, perdenti, prodotti della globalizzazione. Quello che i molti denigratori non riescono a vedere è che ciò che più ha attirato i giovani palestinesi verso questa forma musicale non è lo stile di vita hip-hop ritratto nei video musicali commerciali, fatto di soldi e donne seminude, ma la possibilità di esprimersi senza vincoli riallacciandosi alle radici della cultura hip-hop statunitense degli esordi. Una fonte di ispirazione imprescindibile è data dal gruppo americano Public Enemy. Proprio riferendosi a loro Tamer Nafar, leader del gruppo Dam,afferma: “Chuck D ha detto che la musica rap è la Cnn della strada. Quindi in questo caso il rap palestinese è Al Jazeera. Un ragazzo insegue una ragazza lungo la spiaggia con un fiore. Non è la mia realtà. La mia realtà è data da me che scappo quando la polizia sta cercando di spararmi addosso”.
Altro rapper amatissimo in Palestina, al pari dei Public Enemy, è 2Pac Shakur. Nei suoi video, in cui è inseguito dalla polizia, molti giovani palestinesi vedono se stessi alle prese con i dolori quotidiani. Mahmud Jreri del gruppo Dam afferma: “A noi 2Pac ha insegnato la lingua inglese attraverso le sue canzoni. Mi ha colpito subito. Parlava di problemi politici, sociali e personali, gli stessi che dobbiamo affrontare nella mia città natale Lod, che è al primo posto per quello che riguarda il crimine in Medio Oriente”.
Ma per le strutture di potere locali l’hip-hop non rappresenta un buon modello da seguire. Viene considerato da molti una dannosa importazione occidentale, che corromperà la musica araba tradizionale e la società tutta. A questo proposito Abeer Zinati, in arte Sabreena Da Witch, dice: “Il mio obiettivo è non solo provocare l’establishment israeliano, ma l’intera società palestinese. Non capisco come sia possibile che le donne palestinesi abbiano il più alto tasso di istruzione del mondo arabo-mussulmano e continuino a rimanere intrappolate in una cultura patriarcale che le considera principalmente per il loro ruolo di madri e mogli, anziché dotate di forza e creatività tali da contribuire al cambiamento in positivo della società”. Il suo deridere la religione organizzata e i costumi tradizionali arabi ha fatto sì che il suo lavoro sia rimasto per molto tempo confinato in ambito underground. Si è da tempo trasferita negli Stati Uniti, a Baltimora, ed è riuscita a realizzare quel disco che in patria non è mai riuscita a fare, composto da canzoni scritte negli ultimi dieci anni.
Questa sfida ardente alla visione stereotipata del conflitto in Medio Oriente e della società araba ha dato vita a realtà unite ma distinte a causa della frammentazione territoriale. Pur mantenendo una continuità stilistica, le problematiche particolari affontate variano secondo i luoghi di provenienza. Per questo possiamo affermare di trovarci alle prese con tre scene precise: i Territori occupati, Israele o Palestina 48, come amano chiamarla i giovani rappers (ma non solo loro), e Gaza.
I rappers provenienti da città all’interno di Israele dovrebbero essere cittadini a tutti gli effetti, ma cosi non è. Le città a maggioranza araba sono abbandonate a un degrado pauroso e la polizia israeliana avvelena la società, permettendo lo smercio di droghe al fine di danneggiare il tessuto sociale. Tutti i ragazzi sono oggetto di quella che viene chiamata “educazione shabak”, un eufemismo per descrivere le molestie, a volte violente, che molti di loro sperimentano per mano dei servizi di sicurezza israeliani. Se per caso hanno avuto sfortuna di crescere e vivere in un campo profughi, allora non sono più cittadini di serie B, per loro non esiste neppure una categoria. La vita che devono affrontare è difficile ma dispongono di corrente elettrica, studi di registrazione e possono spostarsi più o meno a piacimento. Aspetti scontati, ma non concessi, per esempio, a un abitante della Striscia di Gaza o “Hamas-stan”, come viene definita dai commentatori dei media americani. Nel più grosso campo di concentramento a cielo aperto niente è scontato. I servizi primari come acqua, corrente elettrica, gas e comunicazione sono molto precari, quando ci sono. Malgrado ciò, si è sviluppata una scena hip-hop tra le migliori del mondo arabo. Con l’occupazione di Gaza nel 2007 da parte di Hamas si sono verificati decine di attentati contro negozi di dvd, di caffè e saloni di bellezza. I valichi da e per la Striscia sono stati chiusi, così come l’unica centrale elettrica, per mancanza di carburante. A volte la corrente si interrompe mentre i gruppi sono nel bel mezzo di una registrazione: bisogna dunque ricominciare tutto da capo quando l’erogazione ritorna. A causa di problemi di alimentazione, l’elettricità arriva solo per 6 ore su 24. Ma i ragazzi non demordono e vanno avanti a discapito delle difficoltà, anche se a volte si vedono interrompere un concerto da qualche membro di Hamas, che entra in sala e comincia a sparare al soffitto. Ognuno degli artisti provenienti da Gaza merita rispetto solo per il fatto di fare musica in una situazione del genere.
Nei Territori occupati, paradossalmente, si è sviluppata una scena più cosmopolita grazie anche al passato avanguardistico (passatemi il termine) di città come Ramallah. Abituati a sentir nominare le città dei Territori solo in caso di attentati, rivolte e occupazioni, tendiamo a dimenticare, o non vogliamo conoscere il vero stato delle cose. Al tempo della seconda Intifada, esplosa il 28 settembre del 2000, Ramallah poteva vantare una brillante vita culturale. Sede del Parlamento palestinese, dei vari ministeri, di molte rappresentanze diplomatiche straniere, capitale virtuale del mai nato Stato, per anni è stata considerata la Parigi della Cisgiordania ed era ricca di caffè, locali e una vivace vita notturna. Il rap proveniente dai Territori è perciò piu aperto e innovativo. Rappers, videoartisti e poeti collaborano insieme e cercano di raggiungere i giovani in giro per il mondo in un momento in cui i media tradizionali raramente propongono un punto di vista palestinese non filtrato. Cosa non secondaria, essere musicisti offre a questi giovani artisti possibilità negate alla maggior parte dei loro coetanei. Possono viaggiare al di fuori del paese per far conoscere le loro storie a un pubblico più ampio (anche se va detto che per gli abitanti di Gaza le cose sono un po’ più complicate). Proprio a Ramallah si è svolto nel giugno 2009 l’HipHopKom, il primo contest dedicato al rap palesinese, creato dall’associazione artistica Sabreen per lo sviluppo in collaborazione con il governo danese. L’evento ha coinvolto 50 tra gruppi e solisti provenienti da tutta la Cisgiordania. A causa del pantano geopolitico attuale, i rapper della Striscia di Gaza non sono riusciti a raggiure Ramallah e si sono collegati con i loro compagni in videoconferenza. Giudici del concorso sono stati rappers arabi provenienti da tutta la diaspora palestinese. Tra questi,Shadia Mansour, l’egiziano Zaki e Shuel Nafar dei Dam. Vincitore del concorso è risultato un gruppo in forte ascesa, proveniente dalla Striscia, chiamato Darg Team, che ora avrà la possibilità di registrare un disco in Danimarca.
Comunque, che provengano da Israele, dai Territori o da Gaza, ciò che accomuna tutti i ragazzi di questa stimolante scena hip-hop è la sete di libertà e innovazione, la ribellione contro il razzismo strisciante e la sfida continua per uscire da quell’impasse alla quale è giunta la gioventù araba a tutti il livelli. In un Medio Oriente senza pace e giustizia da ormai troppi anni è nata una nuova forma di resistenza socioculturale che ha rispolverato la vecchia etica del “do it yourself” cara ai movimenti di fine anni ‘70. Per rispondere ad un amico che mi chiedeva se esistono i punk nel mondo arabo, dico che non c’è nessuno più punk di un giovane rapper palestinese. Nessuno si aspetta un contratto o la possibilità di incidere per una major. Trovo entusiasmante che due amici poco più che bambini si trovino, scrivano un pezzo, ci rappino sopra e postino tutto in rete in tempo reale. Basta fare un giro su Youtube con le coordinate giuste e si trovano moltissimi video ultra artigianali in cui ragazzini imberbi cantano la loro rabbia verso un mondo che gli è ostile o semplicemente esprimono affetto verso la ragazza amata (habibi). Tutto questo forse non cambierà le cose ma, come dice Tamer Nafar, potrebbe essere “la scintilla che accenderà le menti di chi il mondo lo potrà cambiare”.
Ma è inutile continuare a raccontare storie. In un post precedente avevo presentato alcuni tra i protagonisti di questa scena. Voglio ora allargare il campo. Dopo mesi di ricerca sono riuscito a scovare, se non tutti, moltissimi rapper operanti in Palestina. Di alcuni le notizie sono scarsine, di altri si sa qualcosa di più. C’è chi è più barricadero, chi pone l’accento sullo stile e chi si orienta verso tematiche più ludiche. Alcuni sono molto interessanti, altri decisamente limitati dal punto di vista musicale. Tutti comunque rappresentano genuinamente se stessi e le varie anime che popolano l’universo giovanile mediorientale. Collegandomi al tema finora sviluppato, ho diviso i gruppi per aree geografiche di appartenenza. Ecco i protagonisti.