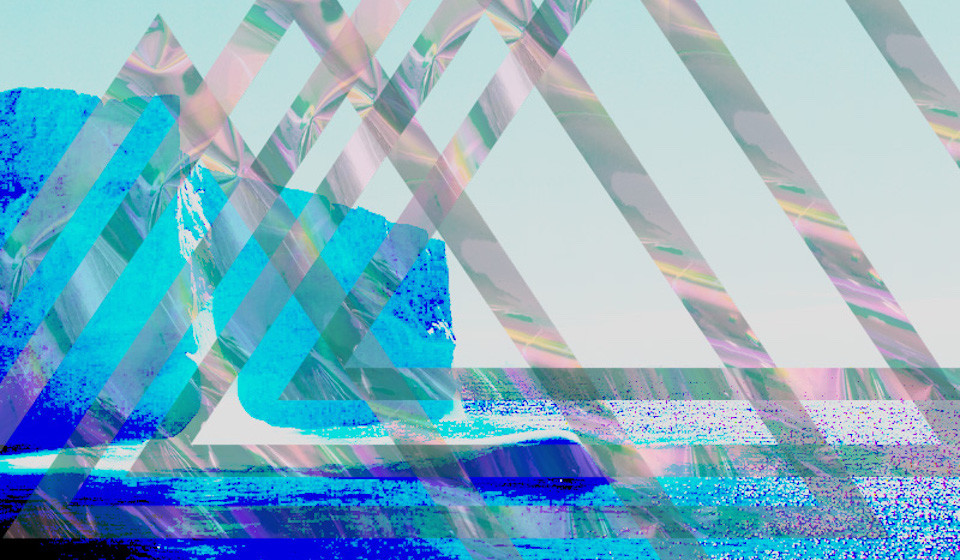
Riscaldamento globale, climate change, definizioni buone per includere in due parole qualcosa che compromette radicalmente l’esistente in una forma subdola, a-percettiva ma che, inesorabilmente, trasforma il rapporto del pianeta con noi umani. Si badi bene: del pianeta Terra con noi umani, non noi umani con il pianeta Terra; l’azione in questo caso è tutta sbilanciata verso la Terra, che nell’arco di una manciata di millenni, pochi secondi in età geologiche, abbiamo compromesso, ma solo dal punto di vista della coesistenza fra essa e quella cosa che definiamo comunemente “vita”.
Un paio di settimane fa, sul giornale inglese The Guardian è stato pubblicato un articolo che riportava i dati raccolti nella foresta pluviale del Porto Rico dal biologo Brad Lister, durante una ricerca compiuta nel 2018, a esattamente 35 anni dalla prima visita in quei luoghi.
Il risultato della ricerca comparativa è stato agghiacciante: il 98% degli insetti terrestri era scomparso. Sparito da una delle aree più protette al mondo, un parco nazionale, quello della Sierra de Luquillo, importantissimo dal punto di vista della biodiversità e quindi preservato dall’intervento (diretto) umano.
Il collasso degli insetti, che sono alla base della catena alimentare, ha portato direttamente ad una diminuzione di anfibi e uccelli del 50-60%.
Quelle parentesi sono importanti, fondamentali per avere libero accesso all’inquietudine più abissale. A questo punto della storia, a questo stadio ultra-avanzato del neoliberismo di sfruttamento, non è necessario l’intervento distruttivo diretto dell’uomo per devastare un ecosistema. Aree iperprotette del pianeta sono oramai inficiate dalla struttura stessa della nostra società umana: riscaldamento globale, alterazione dell’ecosistema a livello atmosferico e macroscopico stanno distruggendo anche le aree definite protette del pianeta senza che vi sia un’azione diretta.
Disboscamento intensivo, monocoltura, fracking, smaltimento di rifiuti industriali e altre mille devastanti attività umane di sfruttamento dei territori hanno inquinato senza possibilità di recupero, in tempi compatibili con la vita umana, parti consistenti del pianeta.
Ma l’impatto globale delle attività umane praticate nella maniera attuale, lo sfruttamento intensivo dal punto di vista energetico e delle emissioni dell’antropocene (l’era geologica dell’essere umano) nella sua fase economica di tardocapitalismo sta cambiando la struttura chimico-biologica del pianeta su scala, appunto, planetaria.
Surriscaldamento globale, acidificazione degli oceani, aumento della co2 atmosferica e a sinergia distruttiva di questi tre fattori stanno uccidendo il pianeta.
Lo stanno facendo in una maniera peculiare, dal punto di vista della percezione umana; il progredire della distruzione è velocissimo, tanto che alcuni studi danno il termine ultimo per il punto di non ritorno climatico in 10-12 anni, eppure per l’umanità questo è un processo che, se addirittura non è percepito, quantomeno è ritenuto distante, siderale, irraggiungibile de facto.
Per il filosofo inglese Timothy Morton questa sfuggevolezza è dovuta al fatto che il riscaldamento globale è un “iperoggetto”, ovvero un qualcosa, un oggetto che è labile alla nostra reale percezione ma nel quale trascorriamo la nostra intera esistenza.
Il riscaldamento globale è l’iperoggetto per eccellenza per Morton. Un qualcosa talmente smisurato come dimensione spazio-temporale da incrinare globalmente la realtà ad un livello non percettivo, ma che inficia a fondo la possibilità di un futuro per il genere umano nella sua totalità.
Per Morton, la fine del mondo, è già iniziata. Alcune avvisaglie possono essere ogni tanto percepite, come la sparizione della quasi totalità degli insetti da una foresta pluviale iperprotetta. Avvisaglie che ci impongono la visione siderale di questo iperoggetto facendoci percepire la sola cosa che ci mette di fronte all’universo nudo: la tragica realtà che non c’è un “fuori”.
“Iperoggetti” di Timothy Morton è edito da NOT – Nero editions
Autore
ph. elaborazione Elio Balbo




